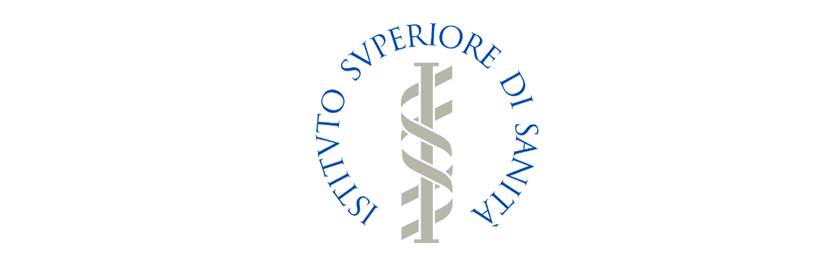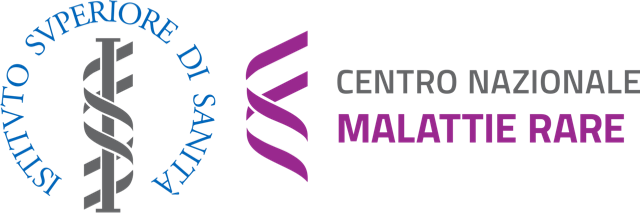NEWS
XVI Giornata Mondiale della Sclerosi Sistemica: luci accese sulla patologia, un trial con le CAR-T e, al Gemelli, una nuova procedura diagnostica
Il 29 Giugno si celebra la XVI Giornata mondiale della Sclerosi Sistemica (World Scleroderma Day). Per l’occasione, in Italia, la Lega Italiana Sclerosi Sistemica lancia la campagna “Accendiamo le luci sulla Sclerosi Sistemica” che prevede nella notte tra il 29 e il 30 giugno di illuminare di viola edifici storici, palazzi, fontane e piazze di più di 60 comuni italiani. Un’azione simbolica per mostrare vicinanza alle persone che vivono con questa malattia rara e ai loro familiari.
La sclerosi sistemica, nota anche come sclerodermia, è una patologia rara autoimmune sistemica che colpisce il tessuto connettivo, causando indurimento e restringimento della pelle e degli organi interni. Essendo multisistemica e multiorgano, in alcune delle sue forme, può risultare fortemente degenerativa e invalidante. Esordisce nel 90% dei casi con il fenomeno di Raynaud, che vede le estremità delle mani cambiare colore a causa di una vasocostrizione. In Italia colpisce circa 30 mila persone, principalmente donne in età fertile, e, pur non esistendo ad oggi una cura definitiva, vi sono nuovi farmaci sperimentali per la cura delle complicanze e protocolli di cura validati a livello internazionale.
Il Gruppo Italiano Lotta alla Sclerodermia (GILS) dà notizia in un comunicato stampa di un recente studio pubblicato sul New England Journal of Medicine in cui si suggerisce che la terapia con le CAR-T (Chimeric Antigen Receptor T cell) potrebbe essere utile nel trattamento di malattie autoimmunitarie, inclusa la sclerodermia.
Si tratta di una terapia basata su linfociti T prelevati dal sangue di un paziente e ingegnerizzati in laboratorio per renderli in grado di eliminare specifiche cellule bersaglio una volta reintrodotti nel sangue dello stesso paziente. Ad oggi questa strategia terapeutica è approvata per il trattamento di alcuni tipi di leucemia e linfoma in cui il bersaglio da eliminare sia costituito dai linfociti B tumorali. Poiché la sclerodermia è una malattia nella quale il sistema immunitario attacca la pelle e gli organi interni, essa è caratterizzata dalla presenza di linfociti B “autoreattivi” che producono “autoanticorpi”.
Nello studio, condotto su 15 pazienti, di cui 4 con sclerosi sistemica, i ricercatori hanno osservato una riduzione dei sintomi/segni e dei biomarcatori di malattia con una singola infusione di cellule CAR-T dirette contro i linfociti B, con un follow-up di un anno. Sta per iniziare ora uno studio clinico multicentrico internazionale che vede coinvolte numerose Scleroderma Unit costituite grazie al sostegno di GILS.
Inoltre, è di questi giorni la notizia che al Policlinico Gemelli è stata effettuata, per la prima volta, una PET/TAC con FAPI (Fibroblast Activation Protein Inhibitor) su due pazienti con sclerosi sistemica. L’innovativa procedura diagnostica con questo nuovo radiofarmaco consente una diagnosi di precisione dell’interessamento polmonare, nell’ambito delle malattie autoimmuni reumatologiche, come la sclerodermia (dove il polmone è interessato nell’80-90% dei casi) e che potrà guidare la scelta e i timing del trattamento della fibrosi polmonare, frequente in queste malattie. Questo, associato alla ricerca di possibili biomarcatori di diagnosi nel siero e nel liquido di lavaggio bronco-alveolare (BAL) dei pazienti, potrebbe avere importanti ricadute sulla loro gestione clinica, soprattutto grazie ai farmaci anti-fibrosanti già disponibili e a quelli di nuova generazione, di prossimo arrivo.
La ricerca, effettuata in collaborazione tra la Reumatologia e la Radiodiagnostica di Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS (FPG), nasce all'interno di un progetto PNRR 2023 del Ministero della Salute, coordinato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, e con il coinvolgimento, per il reclutamento dei pazienti e l’invio di campioni biologici, di altri due centri reumatologici italiani, quello dell’Università di Cagliari e quello dell’Università Vanvitelli di Napoli.
“Il FAPI – ha spiegato la Dott.ssa Silvia Bosello, ricercatrice di Reumatologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, che ha coordinato l’indagine - è un radiofarmaco che si lega ai fibroblasti (le cellule protagoniste della fibrosi) e che potrebbe aiutarci a distinguere tra una fibrosi in fase attiva, in fieri, e una fibrosi stabilizzata, cioè cicatriziale. Differenziare i pazienti reumatologici nei vari stadi di malattia, ci aiuta a stratificarli, al fine di identificare i pazienti che potranno beneficiare di una terapia anti-fibrotica precoce, quando il danno cicatriziale polmonare non sia ancora consolidato, con la speranza di far regredire le alterazioni fibrosanti, rispetto a quelli con fase di malattia più avanzata e per i quali tali terapie possono solo aiutare a stabilizzare l’entità del danno”.
Malattie correlate
- Data di pubblicazione 28 giugno 2025
- Ultimo aggiornamento 28 giugno 2025