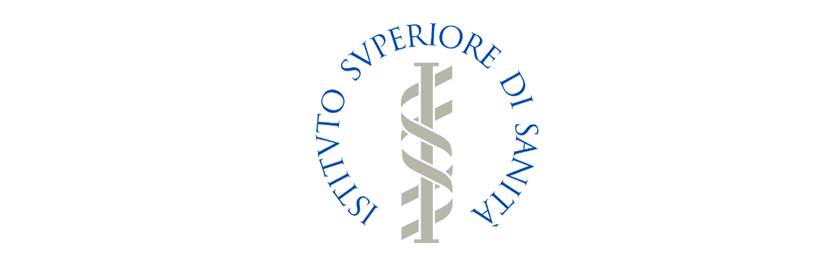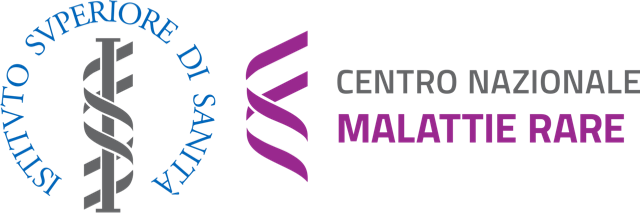NEWS
Malattie rare e qualità dell’ambiente “indoor”: quale prevenzione possibile?
A cura di Domenica Taruscio Presidente del Centro Studi KOS-Scienza, Arte e Società (già Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare, Istituto Superiore di Sanità)
Cosa intendiamo per ambiente “indoor”? Un ambiente chiuso o confinato, quali ad esempio: casa, scuola, luoghi destinati al lavoro, svago, attività sportive, riabilitazione, ai trasporti pubblici (metropolitana, autobus, automobile).
Nell’arco della giornata ciascuno di noi trascorre molto tempo in ambienti indoor, soprattutto considerando il tempo (incluse le ore di sonno) trascorso nella la propria abitazione. Tuttavia, ancora poco si parla del fatto che questi ambienti possono nascondere spesso rischi invisibili per la nostra salute: sostanze chimiche, agenti infettivi, allergeni, radon, particolato.
L’atmosfera indoor è il veicolo principale dei rischi e le fonti sono svariate, quali ad esempio: la inadeguata aspirazione dei prodotti da combustione (cottura dei cibi, riscaldamento, camini); caratteristiche dei locali (elevata densità abitativa, umidità); pulizia (insufficiente oppure erronea per l’uso eccessivo di prodotti detergenti o combinazioni di questi); sostanze chimiche rilasciate da materiali da costruzione e arredi; interscambi con l’ambiente esterno, come nel caso di edifici situati vicino a strade ad alto traffico e conseguente inquinamento atmosferico. A questi si sommano i comportamenti e le scelte individuali quali ad esempio il fumo di tabacco.
Pertanto, possiamo affermare che gli ambienti indoor sono “ecosistemi”, profondamente influenzati da fattori fisici, chimici, biologici, sociali e culturali.
Numerose evidenze scientifiche indicano che gli ambienti indoor insalubri, aumentano i rischi di insorgenza di patologie e disturbi in tutto l’arco della vita - a partire dalla gravidanza sino alla vita adulta. Fra questi vi sono in primo luogo le patologie respiratorie: infiammazioni delle vie aeree con aumenta suscettibilità alle infezioni virali e batteriche, asma, allergie, etc. Ma non bisogna dimenticare le patologie cardio-circolatorie, il basso peso alla nascita, alterato sviluppo neuro-comportamentale con deficit cognitivi e di attenzione, aumentata predisposizione alla obesità, nonché aumentata esposizione a cancerogeni ed interferenti endocrini.
Tutti noi siamo esposti ma esistono fasce di popolazione più vulnerabili. In primo luogo, abbiamo i bambini, in quanto ancora in fase di sviluppo e con una maggiore frequenza respiratoria rispetto agli adulti, nonché con comportamenti (es. il contatto mano-bocca) che aumentano l’assunzione di sostanze presenti nella polvere indoor. A questi si aggiungono i numerosi adulti e anziani con patologie cardio-respiratorie croniche, che possono venire significativamente aggravate dall’ambiente indoor insalubre. Non certo ultimi, fra le fasce vulnerabili è indispensabile considerare le persone con specifiche malattie rare.
Queste ultime soprattutto se colpite da patologie che interessano, direttamente o indirettamente, il sistema respiratorio, cardiaco, muscolare (es. scarsa espansione toracica, scarsa autonomia motoria) ecc., rappresentano una fascia a maggior rischio, in quanto trascorrono mediamente più tempo negli ambienti indoor e pertanto oltre alla patologia di base a questa si sovrappone l’insalubrità dell’aria respirata e delle superfici di contatto. A questo va aggiunto che molte malattie rare interessano l’età pediatrica, che - come già detto - presenta una maggiore vulnerabilità alle esposizioni indoor. Purtroppo, manca ancora una valutazione sistematica delle suscettibilità di specifiche malattie o gruppi di malattie rare ai fattori di rischio indoor. Questi sono, tuttavia, determinanti per alcuni disturbi come, ad esempio, la “sindrome da edificio malato”, una situazione in cui gli occupanti di un edificio sperimentano effetti sulla salute che sembrano essere legati al tempo trascorso all’interno, senza essere in presenza di una malattia specifica.
Per aumentare la consapevolezza e riconoscere l’importanza della salubrità degli ambienti indoor e condividere esperienze e saperi e soprattutto azioni di prevenzione basate su evidenze scientifiche, il Centro Studi KOS-Scienza, Arte, Società, dal 2023 ha lanciato un programma di iniziative coinvolgendo un ampio spettro di istituzioni (Senato della Repubblica Italiana, Istituto Superiore di Sanità), ricercatori, clinici e soprattutto pediatri, Associazioni (es. Cittadinanzattiva) e Federazioni di malattie rare.
Le riflessioni sulle analisi di impatto dell’inquinamento indoor sul benessere e la salute, in particolare dei bambini, sono state condivise con la comunità scientifica mediante la pubblicazione dell’articolo “The impact of indoor air pollution on children's health and well-being: the experts' consensus” (Bozzola et al. 2024).
Identificare, valutare, prevenire o almeno ridurre i rischi per la salute, legati agli ambienti indoor, implica anche riconoscere la complessità delle componenti che influenzano la salubrità, rendendo tali ambienti dei piccoli “ecosistemi”.
La tutela e promozione della salubrità dell’ambiente indoor richiede, quindi, sia di affrontare ed interpretare la complessità sia di integrare le diverse e crescenti evidenze scientifiche in una visione e strategia complessive: queste vanno basate sulla prevenzione primaria e sostenute da evidenze scientifiche interdisciplinari.
Ma come procedere?
Innanzitutto, è necessario aumentare l’informazione circa comportamenti consapevoli che promuovano un abitare sano e simultaneamente intraprendere azioni concrete. In parallelo occorrono norme e linee guida aggiornate in base alle evidenze scientifiche, una migliore sorveglianza epidemiologica degli effetti dei rischi indoor. Importantissime le azioni migliorative: innovazioni tecnologiche, anche con sostituzione di processi e materiali a rischio, uso di dispositivi per favorire il filtraggio e il ricambio di aria e verifiche di salubrità degli edifici secondo criteri condivisi e solidi.
Queste azioni vanno integrate in una visione e una strategia complessiva che incentri le azioni di prevenzione sui gruppi vulnerabili, che in realtà - complessivamente - rappresentano una frazione importante della popolazione generale.
- Data di pubblicazione 11 dicembre 2024
- Ultimo aggiornamento 11 dicembre 2024