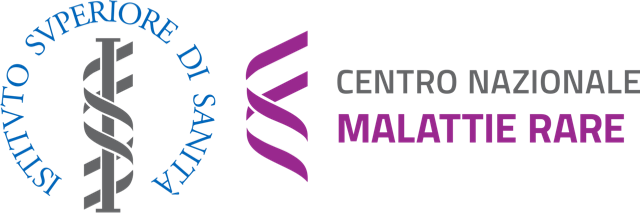NEWS
Sitting volley, “in squadra ci prendiamo cura l’uno dell’altro”
Francesca Fossato, 37 anni, palleggiatrice della squadra italiana di sitting volley alle paralimpiadi di Tokyo, nel 2017 perde una gamba in seguito a un incidente in moto. Ha la passione, fin da piccola, per la pallavolo e fa di mestiere la fisioterapista all’ospedale Mauriziano di Torino: due elementi – la passione e il lavoro – che la aiuteranno, insieme a una buona dose di coraggio e determinazione, e a un pizzico di ironia, a diventare l’atleta che è tuttora. Oggi racconta a RaraMente la sua esperienza.
Francesca cos’è il sitting volley?
“È la pallavolo paralimpica con le stesse regole fondamentali della classica, le uniche grandi eccezioni riguardano il fatto che, come il nome suggerisce, si gioca da seduti spostandosi sul campo con l’ausilio degli arti superiori, motivo per il quale il campo è più piccolo, la rete è più bassa data la distanza minore a cui la palla viaggia da terra, si “mura” nella battuta e, ultimo ma non per importanza, esiste un fallo in più: il list, non è consentito infatti alzare il bacino o il tronco (per chi gioca disteso) da terra essendo questa la caratteristica principale di questa disciplina”.
Uno sport che negli ultimi anni si è affermato sempre più nel nostro paese ma anche a livello internazionale.
“Sì ma con delle differenze. Nel campionato italiano possono giocare persone senza disabilità, con la conditio sine qua non che vi siano almeno due persone disabili in campo. Questo lo rende molto inclusivo: molte persone non portatrici di disabilità che smettono di giocare a pallavolo per motivi legati ad infortuni che ne hanno compromesso la qualità delle prestazioni sportive, come problemi ai legamenti o ai tendini, si avvicinano al sitting volley per continuare a giocare. I colleghi stranieri, invece, tendono ad essere più stringenti: il sitting volley in alcuni paesi è considerato uno sport agonistico a tutti gli effetti, i giocatori non svolgono altri lavori paralleli per poi ritrovarsi a giocare ma intraprendono una vera e propria carriera sportiva, per citare alcuni esempi la nazionale americana ha già collezionato ben quattro medaglie d’oro alle paralimpiadi e tra le squadre più brillanti c’è quella della Bosnia Erzegovina, composta per lo più da reduci di guerra che, dopo aver subito danni invalidanti, trovano la loro strada in questa disciplina. Inoltre, c’è da dire che mentre di solito negli sport paralimpici si viene divisi per “categorie” nette basate sul tipo di disabilità di cui ogni atleta è portatore, nel sitting volley esistono solo due categorie: le disabilità considerate “totali”, ovvero quelle che compromettono profondamente le capacità motorie, e quelle “minime”. Il regolamento prevede che ogni squadra, composta da sei giocatori, abbia cinque atleti la cui diagnosi è di disabilità totale e uno con disabilità minima e i cambi tra campo e panchina sono permessi solo per casi speculari”.
Cosa ti ha portato a questa disciplina?
“Ho perso una gamba nel 2017 a causa di un incidente, sono sempre stata una sportiva, una pallavolista. Dopo mesi passati immobile, in cui avevo subito diversi interventi chirurgici, iniziava a prefigurarsi la prospettiva di utilizzare la sedia a rotelle, idea che rifiutavo, d’altro canto sapevo che l’utilizzo di una protesi per fare sport avrebbe cambiato la mia percezione di libertà di movimento. Così ho contattato la sede del Comitato Italiano Paralimpico in Piemonte chiedendogli informazioni riguardo l’equitazione. Parlando con loro è venuto fuori che ero una pallavolista e mi hanno parlato del sitting volley, che, d’istinto, ho escluso. Successivamente però, dopo aver assistito a una partita, ho deciso di scendere in campo, nel giro di poco tempo ero stata convocata alle prove della nazionale”.
Per te oggi il sitting volley è più uno sport o una terapia?
“All’inizio è stato un modo per muovermi senza avere paura di cadere, rifiutavo la sedia a rotelle e non sopportavo lo sguardo pietista delle persone. Sono una fisioterapista: conoscevo già le dinamiche e le difficoltà del percorso che mi si prospettava. Avere una protesi consente un netto miglioramento dello stile di vita di un paziente, ma è accompagnato da una seria di difficoltà che ne compromettono la quotidianità. Quando vediamo spot pubblicitari in cui vi sono atleti paralimpici che corrono velocissimi mettendo in risalto le loro protesi siamo portati a pensare che chi ha una protesi sia iper-performante. In realtà è una vita in cui le incombenze non scarseggiano affatto: oltre al peso fisico della protesi da dover sopportare tutto il giorno ci sono le ferite generate dal continuo contatto della pelle con l’apparato prospettico, ma, come mi ha detto Bebe Vio una volta: esistono due tipi di persone con le protesi: c’è chi si ferma alla prima piaga e chi continua ad andare avanti”.
Tu, a quanto pare, fai parte del secondo gruppo… A tirar le somme, tra il campionato europeo e le paralimpiadi, i risultati sono grandiosi.
“Sì, al campionato ci siamo classificate seconde dopo la Russia, siamo contente soprattutto tenendo conto del fatto che gareggiavamo contro squadre appartenenti a paesi dove il sitting volley è una disciplina agonistica e quindi gli atleti fanno di questo sport la loro professione, mentre noi incastriamo ritiri ed allenamenti nella nostra routine fatta di otto ore lavorative. A Tokyo, la nostra squadra (femminile) è stata la prima nazionale italiana di sitting volley ad essersi qualificata alle paralimpiadi. E’ stata un’esperienza unica: vedere persone così diverse e con così tante specificità riuscire nelle proprie specialità. Ti porta a notare quello che le persone sanno fare, non quello che non sanno fare. Ho visto persone bere con disinvoltura il caffè prendendo la tazzina con il piede. Ti fa capire che nessuno dovrebbe vergognarsi dei propri limiti ma mostrare come è riuscito a superarli”.
Siamo abituati a parlare di eccellenze atletiche paralimpiche in sport per lo più singoli, quanto conta fare squadra dal punto di vista di una persona con disabilità?
“Ho iniziato a giocare a sitting volley prima ancora di camminare con la protesi e credo che questo abbia cambiato la mia visione profondamente. Una mia compagna di squadra, Giulia, mentre ci raccontavamo le nostre storie mi ha detto: “Francesca, tu hai ancora “tanta gamba”, con una protesi avrai un sacco di miglioramenti, riuscirai a far tutto, vedrai”. Per la prima volta, per qualcuno avevo “tanta gamba”, ero una persona con tante possibilità di recuperare e non una da compatire. Oggi la passeggiata in montagna magari no, ma sono autonoma. In un mondo in cui le persone che sono lì a consolarti hanno due piedi, le belle parole non bastano, hai bisogno di qualcuno nella tua stessa condizione, con le tue stesse difficoltà con cui confrontarti e da cui prendere esempio. Siamo molto ironiche riguardo le nostre protesi e la nostra condizione: chi ha le mani fa la coda di cavallo a tutte o apre le bottigliette d’acqua e chi le gambe porta da mangiare o l’acqua a chi non le ha. Ciò che fa la differenza in un sistema che funziona è l’empatia. Vinciamo tutti assieme e perdiamo tutti assieme, non possiamo ignorarci: anche il più bravo deve prendersi cura del più inesperto e viceversa. Ogni mossa deve essere ponderata in base alle esigenze dell’altro: se ho una compagna alla destra a cui manca la mano sinistra, dovrò coprirla maggiormente”.
- Data di pubblicazione 4 novembre 2021
- Ultimo aggiornamento 4 novembre 2021